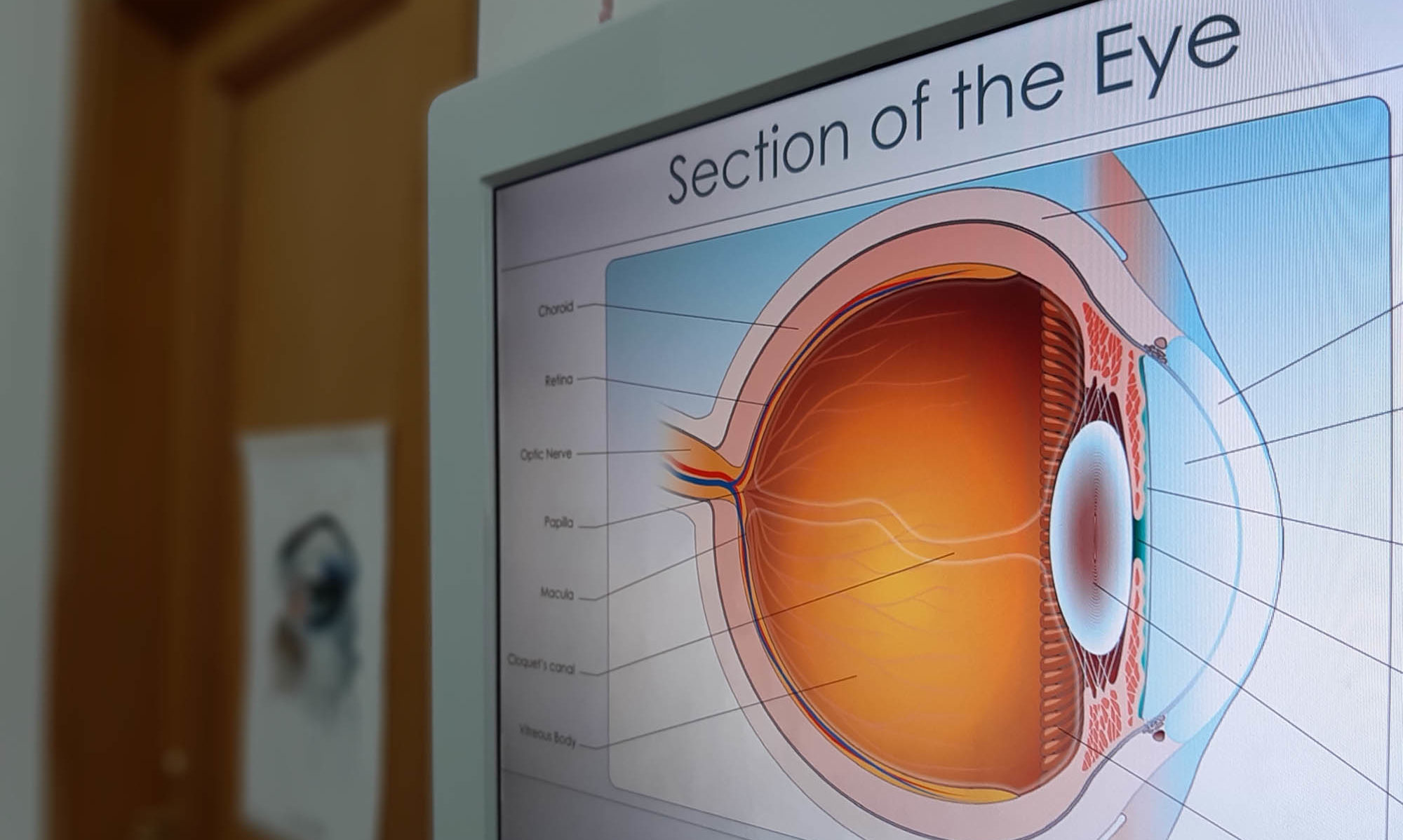Le piante officinali storicamente vengono intese quelle piante utilizzate dagli speziali, i farmacisti del Medioevo
nelle loro botteghe chiamate spezierie o “officine farmaceutiche”, dove si vendevano le spezie e si preparavano i medicamenti a partire dalle erbe medicinali.
Nel XIV secolo, l’età dei Comuni, gli speziali facevano parte dell’Arte dei Medici e Speziali, una delle sette arti delle Corporazioni, il cui compito era quello di svolgere attività di controllo sulla preparazione e serietà degli speziali. A tale Corporazione, si dice, facesse parte anche Dante Alighieri.
Il “papiro di Ebers“, risalente al 1500 a.C., è il più antico documento medico egizio, ascrivibile al regno di Amenohotep I. Il testo rappresenta la più antica testimonianza del largo uso di piante e medicamenti di natura vegetale, che facevano gli Egizi, che in particolar modo conoscevano le proprietà della maggiorana, dell’edera e della mirra largamente utilizzata per l’imbalsamazione.
Nell’antica Grecia, poi, uno dei più importanti studiosi fu il medico Eraclide, padre di Ippocrate, che faceva parte della corporazione degli Asclepiadi, ossia quegli studiosi devoti al dio Asclepio, dio della medicina nella mitologia greca, più noto presso i latini come Esculapio. Eraclide sperimentò nuove ricette, riprese in seguito dall’enciclopedista e medico romano di origine gallica Aulus Cornelius Celsus o Celso.
La raccolta e la vendita dei medicamenti, così diffusa nell’antichità, veniva definita con il termine “farmacopoli“. Questa si basava sulle nozioni contenute nei testi medici scritti da Ippocrate, il padre della moderna medicina; su quelli botanici ascrivibili al filosofo-botanico greco Teofrasto, che ebbe molti contatti con le genti romane, e su quelli di Dioscoride Pedanio, medico, botanico e farmacista che esercitò a Roma all’epoca dell’Imperatore Nerone. Questi nella sua De Materia Medica descrisse più di 600 piante e trattò dell’impiego terapeutico di parecchie sostanze animali, vegetali e minerali.

Nell’antica Roma, poi, a partire dal I secolo d.C., le erbe medicinali erano ampiamente conosciute e coltivate negli orti chiamati appunto “medicinali”. Ampio contributo alle teorie ippocratiche venne, poi, da Galeno di Pergamo, medico di corte dell’imperatore romano Marco Aurelio, i cui punti di vista hanno dominato la medicina europea sino al Rinascimento. Questi fu il primo a considerare la dieta, come parte integrante della terapia medica, attraverso l’uso di frutta, verdura e piante officinali nell’alimentazione quotidiana.
Si deve, poi, ai Saraceni, nel IX secolo d.C. in Sicilia, l’introduzione di nuove tecniche di irrigazione per coltivare diverse specie di piante officinali, ma furono gli arabi che diedero un grande impulso all’alchimia e alla chimica, nello sviluppo farmaceutico di tinture e distillati, che portarono ad organizzare una sorta di farmacopea, recante un elenco di ricette con le proporzioni e le composizioni chimiche delle varie sostanze allora conosciute.
Ma i primi veri testi farmaceutici risalgono agli XI, XII e XIII secolo in cui confluirono tutte le influenze greche, arabe e romane, che riportano le operazioni fondamentali delle preparazioni farmaceutiche: lozione, decozione, infusione e triturazione. In questo periodo, si diffuse l’uso delle spezie e delle droghe e la Scuola Salernitana introdusse, assieme alle pratiche chirurgiche, anche un antesignano dell’anestesia, la spongia sonnifera, che imbevuta di altre sostanze doveva essere aspirata dal paziente prima dell’intervento. La Scuola di Salerno si distinse anche per la grande perizia nel selezionare le erbe, sulle quali abbondano indicazioni terapeutiche ancor oggi efficaci, come l’utilizzo per l’azione espettorante ed antinfiammatoria sul polmone della pianta di Issopo (Hyssopus officinalis)
La botanica, intesa come Scienza, nacque solo agli inizi del Cinquecento, grazie alle scoperte geografiche e alla introduzione della stampa. Si diffusero, infatti, in questo periodo i primi erbari secchi e nel 1533, a Padova, fu istituita la prima cattedra di botanica sperimentale. Risale, infatti, al 1554 il più significativo testo di medicina e di botanica opera di Pietro Andrea Mattioli, umanista e medico, che non si limitò a tradurre l’opera di Dioscoride, ma la completò con i risultati di una serie di ricerche su piante all’epoca ancora sconosciute, trasformando i Discorsi in un’opera fondamentale sulle piante medicinali, un vero punto di riferimento per diversi secoli; nel 1554 fu pubblicata la prima edizione latina dei Discorsi di Mattioli, chiamata anche i Commentarii.
Nel Seicento, poi, fu Pierre Magnol, botanico francese, che analizzando la parentela fra le varie specie vegetali, apportò una sostanziale innovazione allo schema di classificazione botanica, ancora in uso, introducendo le fumigolie, suddividendo, così, il mondo vegetale in settantasei gruppi.
Ma fu solo nel 700, che gli studi botanici ebbero il maggior impulso grazie al medico, botanico e naturalista svedese Carl Nilsson Linnaeus, divenuto Carl von Linné dopo l’acquisto del titolo nobiliare e noto come Linneo, che identificò le specie viventi sistematizzandole in classi, ordini e generi.
LETTURE CONSIGLIATE
- http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id3616&area=farmacia&menu=med
- A. Bruni, M. Nicoletti Dizionario ragionato di erboristeria e di fitoterapia – Piccin Ed. 2003
- E. Campanini: Dizionario di fitoterapia e piante medicinali, 3°ed Tecniche nuove Ed. 2012
- R. Dujany :Manuale pratico di omeopatia familiare e d’urgenza – Red Ed. 2004
- D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin, V. Saint Jean : Farmacologia e materia medica omeopatica – Tecniche Nuove Ed. 1999
- Max Tétau: La materia medica omeopatica clinica e associazioni bioterapiche – IPSA Ed. 2007
ICONOGRAFIA
Foto tratte da: https://pixabay.com/it/